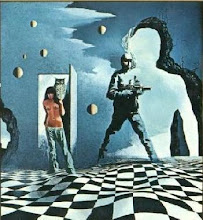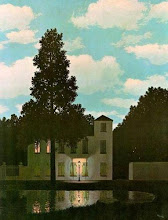Dall’alto del colle Angalf, Signore di Endor, fissava gli squadroni dei suoi lancieri, le sue truppe scelte, allineate nella pianura.
Le nere armature bordate d’oro e le lunghe picche rivolte verso il cielo stellato risplendevano di sinistri bagliori argentei.
Un silenzio irreale era calato sulla valle, gli uomini attendevano gli ordini ed i capi squadrone aspettavano solo un cenno del Duca per muoversi mentre Angalf, li osservava in silenzio.
Quegli uomini erano, la sua guardia scelta, le truppe più temute dei Cavalieri Teutoni, con i quali da anni seminava il terrore e la morte lungo tutte le terre selvagge della Livonia Orientale.
Quegli uomini, con i quali aveva condiviso l’odore acre degli incendi, il sangue ed i volti terrorizzati delle loro vittime ed il comune disprezzo per quei popoli pagani.
Le schiere dei Cavalieri del Supremo Ordine Teutonico, ormai da settimane, stavano mettendo a ferro e fuoco le regioni orientali della Livonia, nell’ennesima Crociata contro gli infedeli.
Angalf amava, nonostante tutto, quegli uomini, ai quali avrebbe potuto chiedere qualsiasi sacrificio e che sapeva lo avrebbero seguito sino in Terra Santa, a liberare il Santo Sepolcro dai Saraceni, non certo perché mossi da una fede sincera nelle Scritture, bensì perché la guerra e la morte erano l’unico elemento che ormai li accomunava.
Ma Angalf era stanco di rincorrere il suo destino, di fingere di credere in un Dio che aveva ormai abbandonato negli occhi delle sue vittime o nel sangue ancora fumante, che zampillava dal collo di un contadino appena sgozzato.
La sua anima era persa, volata via d’un tratto come un corvo dal ramo di un albero nel centro di una radura, sul quale solo pochi attimi prima si era posato, esausto, dopo un lungo volo.
Era stanco di quella guerra, così come della sua stessa vita; entrambe non avevano per lui più alcuna attrattiva, continuare sarebbe stato solo un’ennesima bugia in una vita in cui la falsità era divenuta la compagna inseparabile della propria coscienza.
Il nitrito dei cavalli immobili nella valle, le nuvole di fiato che uscivano dalle narici dei suoi uomini e dalle loro cavalcature lo distolsero per un attimo da questi pensieri, mentre una stella ancora più luminosa parve balenare nel cielo stellato, attirando per un attimo la sua attenzione, verso un lontano spicchio di cielo stellato in alto, dinanzi a lui.
Il chiarore di una Luna quasi diafana illuminava la pianura, silenziosa spettatrice dei loro destini.
Un cavaliere improvvisamente si mosse da quelle schiere ordinate e, con un lento trotto, attraversò le prime file, raggiungendo le pendici della collinetta ed affiancandosi ad Angalf.
Angalf subito riconobbe nell’uomo il giovane Enkhart di Lusza, il suo luogotenente, così possente nella sua armatura di ferro, con quel suo sguardo fiero ed i lunghi capelli corvini, che, prepotenti, spuntavano da sotto l’elmo intarsiato con le insegne della casata degli Hostrasser.
“Quali sono i Tuoi ordini” gli disse Enkhart non appena gli fu giunto accanto.
“Ci ritiriamo” gli rispose Angalf senza neppure rivolgergli lo sguardo, ma continuando a fissare oltre le linee dei suoi uomini ed oltre le loro lance quelle sconfinate distese verdi, interrotte solo qua e là da paludi, qualche collina e punteggiate di radi boschetti di abeti.
“Torniamo al castello di Kaunas” - aggiunse Angalf spostando il suo sguardo su Enkhart e fissandolo a lungo negli occhi – “ sono stanco di questa scorreria e sono stanco di imporre con il sangue una fede che forse non ho mai avuto”.
“Ma Signore..” disse Enkhart “….proprio adesso che siamo a soli venti chilometri dalla città di Dunaburg, dove dobbiamo ricongiungerci con le truppe del Gran Maestro di Marienburg”.
“Vai Tu, se vuoi, prenditi quattro squadroni e lasciami i due della mia guardia personale. Lascerò a Ludwig e Freizer di decidere liberamente se seguirti con i loro uomini o se tornare ad Kaunas con me.”
“Gli uomini non mi seguirebbero senza di Te” – riprese Enkhart – “e neppure Ludwig e Fraizer lo farebbero”
“Allora dì loro che torniamo indietro” – aggiunse Angalf – spronando improvvisamente il cavallo verso Ovest giù dalla piccola collina in direzione di Kaunas, scomparendo in fretta agli sguardi dei suoi uomini.
La fredda brezza notturna quasi bruciava il volto e faceva lacrimare gli occhi, mentre in un galoppo sfrenato Angalf percorreva la pianura, attraverso stagni paludosi semi ghiacciati ed un terreno indurito dal gelo.
Percorse alcune miglia, fermò la sua corsa nei pressi di un boschetto e, voltatosi indietro, vide i suoi uomini che, in squadroni ordinati, lo seguivano al galoppo, riconoscendo in testa la sua guardia personale e dietro Enkhart con a fianco i mercenari di Ludwig e più staccato, in posizione di retroguardia, come suo compito, Fraizer e i suoi teutoni.
Angalf li attese per poi cavalcare alla testa della colonna, per il resto della notte, in un silenzio irreale, rotto solo dal rumore delle loro cavalcature sulla pianura, mentre quelle terre di frontiera mostravano, al loro passaggio, il loro volto arido e desolato.
Ai primi albeggi Angalf ordinò di arrestare la marcia e di far riposare gli uomini per alcune ore, assegnando la sorveglianza del bivacco ai lancieri della sua guardia personale per poi, stremato, coricarsi a fianco del proprio cavallo.
Risvegliatosi solo dopo poche ore di sonno, trascorse in un dormiveglia agitato, Angalf dette ordine di riprendere subito la marcia e, a tappe forzate, guidò i suoi uomini sino alle colline di Elmoran da cui, in lontananza, immerso nel verde, si poteva intravedere la doppia cinta muraria e le alte torri del castello di Kaunas, apparentemente baluardo della cristianità in quelle terre di frontiera, in realtà luogo di efferatezze e crudeltà indicibili e cupo nascondiglio della sua, oltre che di molte altre anime corrotte, dalle luci del mondo.
Mentre si avvicinava a quel regno delle tenebre, attraverso il sentiero che si snodava all’interno della fitta foresta che cingeva, quasi a separarlo dal resto del mondo, il castello, Angalf avvertì che la sua inquietudine, piuttosto che diminuire, aumentava man mano che si avvicinava alla sua dimora, divenendo quasi incontrollabile quando, dal sentiero, cominciava ad intravedere, attraverso la vegetazione, l’alto muro di cinta in pietra nera, con i posti di guardia illuminati dal fuoco dei bracieri accesi sugli spalti che, per suo espresso ordine, ardevano incessantemente giorno e notte, sinistro monito fiammeggiante per i viandanti ad evitare quei luoghi e spettrale anticipo di ciò che, nell’al di là, attendeva le anime dei suoi abitanti.
Un drappo con sopra la croce nera bordata d’oro in campo bianco, simbolo dell’Ordine Teutonico, sventolava dalla torre più alta, ma solo da sotto le mura, si sarebbe potuto distinguere, disegnata su quello stesso vessillo, l’immagine di un corvo dagli artigli sanguinanti, il sinistro emblema scelto da Angalf per se stesso e per i suoi uomini.
Il lungo drappello comparve d’improvviso ai margini dell’ampia radura che circondava il castello, cogliendo quasi di sorpresa i soldati di vedetta sugli spalti, che subito passarono la voce dell’arrivo del loro Signore, abbassando in fretta il ponte levatoio ed aprendo i due pesanti portali di ferro che, di seguito l’uno all’altro, serravano, sorretti da quattro robuste torri, l’entrata principale.
Angalf smontò in fretta di sella non appena entrato nel cortile più interno, dirigendosi a passi veloci verso il palazzo.
Salì in fretta le ripide scale che portavano ai suoi appartamenti, mentre i soldati di guardia si arrestavano inquieti al suo passaggio, interrogandosi se quel ritorno inaspettato dovesse presagire a nuovo sangue e nuovo terrore.
Percorse in fretta i lunghi corridoi e le ampie sale, ancora immerse nell’opaco chiarore dell’alba e rischiarate dalle fiamme delle fiaccole che ardevano lungo i corridoi del palazzo, giungendo infine dinanzi a quella porta, unica meta del suo disperato vagare di quella notte.
Quasi paralizzato, nonostante l’ansia che lo divorava, Angalf attese alcuni minuti prima di trovare il coraggio di spingere lentamente il battente e varcarne la soglia.
Entrato subito la vide, così bella e dolce come se la ricordava, in piedi accanto alla finestra, ancora intenta a cercarlo con lo sguardo giù nel cortile, fra i soldati che, appena arrivati, smontavano le cavalcature.
Era bellissima, i lunghi capelli biondi leggermente mossi, i lineamenti delicati, impreziositi dal colore azzurro degli occhi e da un sorriso celestiale che, quando sorrideva, le illuminava il volto.
Lei si voltò d’improvviso e Angalf, sorridendole, la fissò in silenzio, cercando di fermare quell’attimo di intimità tra loro per l’eternità, mentre lei, raggiante di gioia, attraversava di corsa la stanza per abbracciarlo.
Rimasero a lungo l’uno fra le braccia dell’altra lì in piedi, vicino alla porta, senza dire niente, ascoltando entrambi il loro respiro.
“Ti amo” sussurrò lei “ non credevo che saresti tornato così presto…..avevo così tanto bisogno di te…… che non sapevo più come fare……quando poco fa ho sentito le vedette annunciare il tuo arrivo non riuscivo a crederci… sono così felice” – aggiunse lei con un filo di voce mentre, delicatamente, gli appoggiava il volto sul torace.
Angalf le passò delicatamente le dita tra i capelli, accarezzandole il collo e le guance.
“Ti voglio bene – disse Lui continuando a stringerla forte a sé – … non ce la facevo più a stare lontano da te…sono così stanco di tutto questo sangue, di questo dolore…..avevo così tanto bisogno di vederti ”.
“…sei la mia unica ragione di vita – riprese Angalf, quasi con un sussurro - riesco a reggere a tutto questo solo perché guardando il cielo so che laggiù da qualche parte ci sei tu, con quel tuo sorriso così dolce, con le tue paure…. Sei l’unica parte buona rimasta in me … quello di buono che io avevo un tempo l’ho ormai perso.…senza di te tutto sarebbe solo tenebra.”
Rimasero a lungo abbracciati vicino al fuoco e Angalf pianse in silenzio tra le braccia di lei.
La ragazza, Shena Kassilivi, era la figlia di un notabile lituano che, catturata insieme con la famiglia, durante il saccheggio di Vilasius, venne risparmiata dal Gran Maestro dell’Ordine Teutonico dalle torture e dalle violenze, di cui furono vittime gli altri abitanti ed i suoi stessi familiari, perchè questi aveva pensato di far cosa gradita ad Angalf offrendogliela quale dono di guerra.
Angalf aveva accettato il dono, come era accaduto già molte altre volte, quando alcune ragazze giovani, di solito molto piacenti, gli venivano donate dal Gran Maestro per generosità o semplice complicità.
Erano ragazze con cui Angalf si divertiva una o due notti per poi assegnarle ai servizi domestici di palazzo e che, ai suoi occhi, dovevano ringraziare Dio Onnipotente di non subire la stessa sorte dei loro familiari ed anzi di essere educate nella vera fede.
Ma quando, la prima sera, gli fu condotta in camera la giovane, Angalf nel vederla, ne rimase stranamente turbato, sia per la straordinaria bellezza che per la dolcezza dei modi, così da decidere di affidarla, per alcuni giorni, alle cure di alcune serve ed alla sorveglianza di due lancieri fidati, mentre lui era impegnato in continue scorrerie e scontri di frontiera contro gli slavi; devastazioni sanguinose che delle crociate mantenevano solo il nome, forse per ingannare, come uno stupido alibi, le coscienze di coloro che perpetravano tali efferatezze.
Poi un giorno, nel cortile, al rientro dall’ennesima carneficina, aveva incrociato di sfuggita lo sguardo di Shena mentre, con ancora l’armatura sporca di sangue, smontava da cavallo ed inspiegabilmente si era sentito come nudo ed aveva desiderato solo sottrarsi in fretta a quegli occhi.
Poi due notti dopo, preso da una strana inquietudine, aveva vinto gli indugi e si era recato nella stanza dove dormiva la ragazza trovandola vicino al camino, ancora sveglia, che fissava le braci ardenti.
Avvicinatosi, quasi impaurito, l’aveva vista sorridergli e così era rimasto con lei l’intera notte, così come la notte seguente e quella ancora successiva, meravigliato di come la giovane, pur temendolo, gli dimostrasse il suo affetto, come un giovane cerbiatto indifeso ormai in balia del proprio carnefice, nel quale deve comunque riporre la propria fiducia, affidandogli la propria vita, forse per un senso di speranza, ancora intatto, nei confronti del mondo che lo circonda.
Ed a poco a poco la giovane era diventato questo per lui, l’ultimo barlume di bontà in un mondo di tenebra, un essere indifeso da proteggere dall’odio e dalla crudeltà che li circondava entrambi.
Così d’improvviso si erano resi conto di essersi innamorati, ed ogni notte, chiusi nel loro piccolo mondo, trovavano negli occhi l’uno dell’altra la fuga all’oscurità che li avvolgeva.
Da allora Angalf pur continuando a guidare i suoi uomini in battaglia e ad obbedire fedelmente agli ordini del Gran Maestro, cercava di limitare le efferatezze, frenando, quando poteva, gli eccessi di crudeltà dei propri soldati.
E questi avevano interpretato questo nuovo atteggiamento come frutto piuttosto di quella stanchezza, figlia delle guerre che non trovano mai una fine, che non di un cambiamento, invero per loro inconcepibile, dell’animo del loro Duca.
Nessuno infatti conosceva, né poteva immaginare la verità del sentimento che era nato in Angalf e che lo legava alla giovane lituana.
Tutti, anche gli uomini più vicini al Duca, pensavano infatti che l’assidua frequentazione della giovane da parte di Angalf fosse dovuta più ad un capriccio passeggero, come già altre volte in passato era accaduto, che non ad un vero mutamento interiore.
Ma stavolta Angalf aveva trovato nella ragazza qualcosa a cui non avrebbe rinunciato neppure per tutti i tesori accumulati dall’Ordine a Konisberg, in lei aveva trovato finalmente la pace della sua anima.