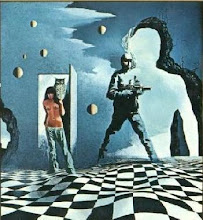Grigia bruma autunnale, radi alberi che si infittiscono e poi di colpo, di fronte a noi, formano un bosco, avvolto anch’esso nella nebbia che, lentamente, si solleva dal suolo in una terra germanica, perennemente impregnata di umidità.
Solo elmi e scudi sulla linea del mio orizzonte ed aliti di vapore frammisti al silenzio, quello assoluto, totale, quello dei pensieri sulla morte e della ferma determinazione, quello della ferrea disciplina e dei nostri valori ancestrali sul coraggio e sull’onore.
Una lunga linea di grigio acciaio e di punte acuminate che, asimmetriche, scompaiono in lontananza.
Profili indefiniti di decine di volti, sagome quasi irreali adesso, anche se da me ben conosciute.
L’attesa …… sempre la stessa come ogni volta, da molti anni.
E l’ansia che diviene palpabile, quasi visibile, come lo scudo di Massimo che copre il mio fianco destro ed il forte braccio di Varo, con l’alto pilum, cui il mio scudo offre riparo, alla mia sinistra.
Il nemico indefinito, informe è di fronte a noi, forse mille, forse solo cento passi; ne percepiamo la presenza, oltre alla sua stessa inquietudine che nasce dal vederci fermi, risoluti… orgogliosamente sicuri della nostra superiorità e che ancora lo frena nel suo desiderio selvaggio di dare battaglia.
Spalla contro spalla, gli uni vicini agli altri, avvertiamo la stessa tensione la stessa ansia che avvolge il cuore, ma siamo determinati, un’unica entità pronta allo scontro, gli occhi fissi dinanzi a noi su sagome indistinte che, forse frutto della nostra attesa, pervadono la nebbia insieme con il nostro immaginario, mentre il comandante Marsilio, immobile, appena fuori della linea formata dai nostri scudi, scruta il limitare della radura, da dove ciascuno di noi vedrà, a momenti, apparire il proprio destino.
Lucio e la IX coprono il nostro fianco destro, non li vediamo, attraverso questa nebbia e questa luce fioca, che fagocita tutto insieme al paesaggio, ma sappiamo che sono là, schierati su quattro linee e pervasi dalla nostra stessa inquietudine.
Come Valerio con la XIV “Virtus” a centoquaranta passi da noi verso est, più al centro della pianura e certo con le lance delle prime file già abbassate in attesa dell’urto.
Il momento delle scelte, il momento dei pensieri oscuri, il momento della raccomandazioni agli Dei, il momento delle certezze, il momento della nebbia della ragione, il momento in cui si fanno risuonare incessanti nella mente le parole del centurione Cornelio, unico ricordo dei molti mesi di addestramento, tante e tante lune orsono, ricordo di un tempo così lontano, che adesso fatichiamo a crederlo veramente vissuto.
L’attesa, terribile compagna che sola ci fa progredire tutti insieme nel nostro coraggio, l’attesa in un sentire comune che ci unisce e ci fonde quasi in un’unica entità, nella quale le nostre individualità scompaiono e nella quale ci nutriamo reciprocamente, l’uno della fermezza dell’altro.
L’attesa, un breve respiro trattenuto, un movimento comandato dal nostro cervello che non viene eseguito, un pensiero percepito nel nascere e immediatamente schiacciato e soffocato con rabbia, traendo forza dal compagno che ci sta al fianco.
Improvvisa la liberazione si materializza dinanzi a noi sotto sembianze di uomini urlanti, selvaggi privi di disciplina che combattono solo spinti dall’odio, che si credono cacciatori mentre moriranno da prede, come altri prima di loro.
La Legione all’unisono si irrigidisce, i muscoli si tendono, le gambe cercano stabilità nel terreno, gli scudi, con un unico movimento, leggermente si alzano per poi contemporaneamente unirsi, quasi spezzando, nell’incastro, le lance che abbassiamo, d’un tratto, protendendole dinanzi a noi.
Ancora cento passi e distinguiamo meglio i loro volti, ancora cinquanta passi e comprendiamo chi sarà il nostro avversario, colui che dovrà morire per permetterci di vivere.
Nella fermezza di chi ci sta al fianco, nel silenzio della sua voce, nella fiducia che in lui riponiamo adesso affidiamo, ciascuno, le nostre certezze e costruiamo l’ultimo nostro rifugio; mentre la mente si ottenebra nell’oscurità della ragione, soffocata da istinti primordiali di sopravvivenza e di rabbia.
Noi che siamo gli ambasciatori della civiltà, i figli di una cultura superiore …
i legionari.
Poi l’urto, terribile, violento, previsto ma che egualmente ci sospinge, ci travolge e ci fa barcollare, mentre vediamo le ferite, il sangue, le maschere di dolore ed accanto un compagno che cade, cui non possiamo prestare soccorso, perché tutti sappiamo che dobbiamo, a costo di qualsiasi sacrificio, tenere la linea.
Il nostro scudo che protegge il compagno e i colpi che sferriamo sono l’unica preoccupazione, unita alla fiducia che lo scudo di chi ci sta a fianco egualmente stia saldo.
Sangue, membra lacerate e colpi violenti inferti, da entrambe le parti, con una ferocia di cui le stesse belve mai si sognerebbero, noi, i portatori della pace, contro loro i barbari, stupidi difensori di usanze ancestrali e costumi primitivi.
Una pressione continua, crescente, che si unisce alle urla ed al rumore assordante del metallo, mentre lo scudo si fa sempre più pesante ed il riflesso ormai connaturato del parare ed infliggere i colpi prende il sopravvento su ogni mio pensiero, su ogni mia titubanza.
Un frastuono sul quale sento chiara solo la voce del comandante, che ci urla di restare immobili e tenere la posizione, mentre Massimo crolla a terra, col cranio fracassato, lasciandomi scoperto sul fianco, ma subito sostituito da un compagno che, dalla seconda linea, avanza d’un balzo, affiancando il suo scudo al mio, chiudendo il varco.
L’orda come un’onda si infrange sempre con maggior violenza, consapevole che, se respinta, verrebbe a sua volta travolta.
Poi il crollo fulmineo ed inatteso, alcuni compagni che cadono, la linea che sbanda, l’urto che, dapprima lineare, si frantuma in mille scontri individuali, mille rivoli di combattimenti corpo a corpo, dove solo l’esperienza ed il Fato comandano, dove, mentre, alla cieca, abbatto il nemico più vicino e recido, di netto, con la daga, l’avanbraccio di un altro barbaro, confido ancora di avere, alle spalle, un compagno, piuttosto che un avversario.
Così libero senza freni il mio furore, mentre colpisco con tutta la violenza e la rabbia di cui sono capace, lottando per la vita ed odo solo il mio urlo primordiale sovrastare il rumore dei colpi.
Ma la Legione è ancora viva e presente, anche se frantumata, ancora lotta disperata per non soccombere, seppur frazionata in mille individualità selvagge.
E a questo punto è il nemico a vacillare, quasi sorpreso da quella resistenza accanita, è l’orda a cercare un elemento che la tenga unita, ora che è riuscita a frazionare quell’avversario che pareva monolitico, è l’orda che sbanda, che indietreggia mentre ancora cerca un riferimento cui aggrapparsi, esaurito il compito che si era prefissa e nello stesso istante in cui la V Legione “Felix”, dalle retrovie ed a ranghi compatti, si immerge nella mischia.
Come una macchina da guerra ben addestrata, le coorti di rinforzo penetrano in file ordinate tra le nostre file residue, frantumano le difese dell’orda e risolvono gli ultimi scontri, lacerando le carni e calpestando corpi ormai mutilati con una progressione lenta ma inesorabile, che, come d’incanto, mi sottrae lo stesso avversario che avevo dinanzi, lasciandomi, da solo, di fronte al suo corpo ora dilaniato, al centro della pianura.
La vittoria grondante di sangue dirada le ultime nebbie che filtrano un sole malato.
Tra i corpi straziati dei nemici e di volti amici ed un fetore insopportabile di sudore adesso vedo la morte sollevarsi, sazia, dal campo di battaglia, recando via con sé molte speranze e molti sogni cui ancora la stessa sera precedente, intorno ai falò, ero stato fatto partecipe e che anch’io avevo condiviso.
Colgo il corpo inerte di Settimo e più in là quello mutilato di Claudio mentre Varo, l’armatura quasi lavata nel sangue, mi si avvicina, quasi a voler di nuovo ricomporre una linea che ormai non esiste più, poi entrambi rispondiamo al richiamo del centurione della VII coorte per raggrupparci, dopo che abbiamo scorto il nostro comandante a terra, privo di vita.
E lancio un ultimo sguardo, quasi di invidia, alla Legione “Felix” che sta inseguendo i barbari nel bosco, mentre da terra raccolgo l’aquila e le insegne della XIX “Civitae” …… la mia Legione.