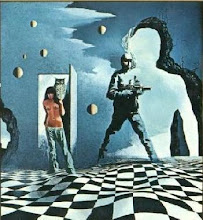Gradini, ancora gradini, i “suoi” gradini. Lentamente saliva quelle scale che conosceva fin da piccola; lì viveva con la sua famiglia dalla nascita e lì sapeva che avrebbe vissuto per il resto della sua vita perché quel palazzo, chiamato Casa Pasqualati, era la sua casa.
Arrivata al quarto piano si fermò davanti alla porta e picchiò forte sul battente. Colpi forti, violenti e ripetuti, a sovrastare la melodia che aveva sentito fin dal primo piano mentre saliva e che adesso, lì sul pianerottolo, si avvertiva distintamente provenire dall’interno dell’appartamento.
Il Maestro come al solito non rispondeva; come accadeva tutte le volte che sia la cameriera che il suo segretario non c’erano. Brigitte la cameriera le aveva detto mezz’ora prima che sarebbe andata al mercato rionale, mentre il segretario l’aveva visto incamminarsi di buon mattino verso l’Hofburg dove si recava quasi ogni giorno.
Che strano uomo il Maestro - pensò tra sé mentre nuovamente picchiava con forza il battente contro la porta - certo assai bravo, ma alle volte così scontroso ed assente; forse a causa della sordità.
“Maestro, la carrozza è arrivata” annunciò urlando a gran voce attraverso la porta e continuando a percuoterla.
Dall’interno la musica si interruppe d’un tratto, sostituita da un improvviso silenzio e poi da un fruscio lontano quasi impercettibile per chiunque, ma non per i suoi orecchi abituati a cogliere ogni minimo rumore, soprattutto se proveniva dall’interno del palazzo.
Rimase lì ferma sul pianerottolo in attesa, fissando la porta ancora chiusa; con l’orecchio attento a cogliere ogni più minimo rumore che provenisse dall’interno. In fin dei conti ascoltare facendo finta di nulla faceva parte del suo lavoro di portierato; ascoltare, osservare ed annotare mentalmente ogni movimento di tutti, di chi entrava, di chi usciva e ricordarsi anche le visite che ognuno riceveva, per essere sempre informata ed anche, alla bisogna, per informare chi di dovere.
E quest’uomo così celebre venendo ad abitare lì aveva alterato la vita di tutto il palazzo, aveva aumentato il via vai. Certo un via vai di persone importanti, ma quanto lavoro in più era arrivato per lei. Adesso, quasi ogni giorno, doveva pulire il cortile antistante, lavare l’androne, spolverare il portone d’accesso e lucidarlo, mentre prima - almeno da quanto le aveva sempre detto sua madre – queste incombenze si rendevano necessarie, al massimo, ogni due o tre settimane. Insomma, da quando il Maestro era venuto ad abitare lì, oltre sei anni prima, tutto il lavoro era aumentato. Poi, come se non bastasse tutti, ma proprio tutti, dai vicini sino alle cameriere e perfino i vetturini o anche semplici passanti, la interpellavano volendo sapere del grande compositore, cosa faceva, chi incontrava, cosa mangiava, come si vestiva, se suonava sino a tarda notte … una vera scocciatura; non era mai lasciata un minuto in pace nella sua guardiola. Certo molti ospiti del Maestro - soprattutto le Signore - le lasciavano mance generose quando lei si occupava di cercargli le carrozze in particolare a tarda sera, ma onestamente ne avrebbe fatto anche a meno, perché per ogni carrozza che arrivava e partiva c’era sempre più sporcizia da togliere nel cortile ed anche dentro l’androne; soprattutto quella assai puzzolente lasciata dai cavalli. E poi, come se non bastasse, d’estate doveva tenere ben umido il selciato antistante l’entrata del palazzo e d’inverno spazzare la neve non solo dinanzi al portone – come gli aveva insegnato sua madre – ma su tutto il piazzale là dove sostavano le carrozze a doppio tiro in attesa degli ospiti del Maestro, arrivando a pulire fin quasi davanti all’entrata del palazzo accanto; perché il vecchio Gerd - che lì faceva il portiere - non ne voleva proprio sapere di andare a pulire oltre l’androne antistante la sua guardiola. Toccava quindi a lei curare che tutto fosse in ordine. Ne andava del buon nome del palazzo e soprattutto di lei e della sua famiglia.
La porta che si apriva lentamente la ridestò da quei pensieri e – come sempre – sfoggiò il suo miglior sorriso di circostanza mentre il Maestro apparve sulla soglia dell’appartamento con lo sguardo un po’ assente.
“La carrozza è arrivata ed è davanti al portone Maestro, sono venuta ad informarla” disse scandendo bene le parole ed a voce alta.
Lui annuì. Aveva capito, pensò lei tra sé.
“Quando vuole può scendere. Ha bisogno di qualcosa?” gli chiese, sapendo che non avrebbe ricevuto, come sempre, alcuna risposta.
Lui, abbozzando un mezzo sorriso, annuì. Almeno aveva compreso si disse lei.
Sul fondo dell’appartamento dietro le spalle del Maestro intravide il salotto ed il pianoforte a coda con gli spartiti sparsi qua e là per la stanza. Una confusione che lei non poteva tollerare in casa sua, ma d'altronde sapeva che i compositori erano tutti, senza eccezione, disordinati. Glielo aveva riferito anche la sua amica Gertrude che frequentava lo stesso fornaio vicino al Naschmarkt dove andava la portiera di quel tal Schubert.
Salutò con garbo il Maestro e si girò per tornare in fretta giù, quando d’improvviso sentì la voce di lui che la interpellava: “Mi scusi signorina…”
“Si” rispose guardandolo anche un po’ stupita, perché raramente le aveva rivolto la parola a causa della sordità che lo rendeva schivo ed introverso.
“Posso chiederle il suo nome?” le disse.
“Elisa, Signor Beethoven, Elisa Steiner … per servirla” - rispose - accennando un breve inchino.
“La ringrazio molto... Elisa … E’ proprio un bel nome – mormorò tra sé il Maestro – delicato e soprattutto musicale … Sì! E’ perfetto.”
“La ringrazio - continuò lui - dica al cocchiere in strada che arrivo subito. Adesso ho davvero finito.”
“Sa talvolta - riprese - un nome è quanto di più difficile ci sia da trovare.”
Ed in fretta si girò e rientrò nell’appartamento lasciando la porta aperta.
Lei lo vide che raggiungeva il pianoforte ed annotava qualcosa, un breve appunto, sullo spartito.
“Che tipo!” mormorò tra sé mentre scendeva le scale “sono più di sei anni che vive qui e solo ora chiede il mio nome.”
Uscita dal portone disse al cocchiere che il Maestro sarebbe arrivato subito e quindi si mise a spazzare l’androne con l’abituale misurata lentezza, simile ad un animale che delimita e controlla il proprio territorio.
Poco dopo lui arrivò, attraversò in fretta l’androne e senza nemmeno degnarla di un saluto salì sulla carrozza che partì subito in direzione dell’Hofburg.
Sotto braccio notò che aveva con sé una cartellina da cui sporgevano alcuni spartiti, quasi certamente quelli che aveva notato poco prima dentro l’appartamento.
Quei fogli bianchi da cui certo uscivano, a volte, melodie molto belle e che in molti suscitavano grandissima ammirazione, ma che a lei non erano mai interessate molto.
Quella musica le sembrava infatti troppo raffinata; era il tipo di musica nella quale si dilettavano i ricchi, sua Maestà e quasi l’intera aristocrazia perché non avevano altro da fare - pensava - mentre a lei non avrebbe mai dato da vivere.
Arrivata al quarto piano si fermò davanti alla porta e picchiò forte sul battente. Colpi forti, violenti e ripetuti, a sovrastare la melodia che aveva sentito fin dal primo piano mentre saliva e che adesso, lì sul pianerottolo, si avvertiva distintamente provenire dall’interno dell’appartamento.
Il Maestro come al solito non rispondeva; come accadeva tutte le volte che sia la cameriera che il suo segretario non c’erano. Brigitte la cameriera le aveva detto mezz’ora prima che sarebbe andata al mercato rionale, mentre il segretario l’aveva visto incamminarsi di buon mattino verso l’Hofburg dove si recava quasi ogni giorno.
Che strano uomo il Maestro - pensò tra sé mentre nuovamente picchiava con forza il battente contro la porta - certo assai bravo, ma alle volte così scontroso ed assente; forse a causa della sordità.
“Maestro, la carrozza è arrivata” annunciò urlando a gran voce attraverso la porta e continuando a percuoterla.
Dall’interno la musica si interruppe d’un tratto, sostituita da un improvviso silenzio e poi da un fruscio lontano quasi impercettibile per chiunque, ma non per i suoi orecchi abituati a cogliere ogni minimo rumore, soprattutto se proveniva dall’interno del palazzo.
Rimase lì ferma sul pianerottolo in attesa, fissando la porta ancora chiusa; con l’orecchio attento a cogliere ogni più minimo rumore che provenisse dall’interno. In fin dei conti ascoltare facendo finta di nulla faceva parte del suo lavoro di portierato; ascoltare, osservare ed annotare mentalmente ogni movimento di tutti, di chi entrava, di chi usciva e ricordarsi anche le visite che ognuno riceveva, per essere sempre informata ed anche, alla bisogna, per informare chi di dovere.
E quest’uomo così celebre venendo ad abitare lì aveva alterato la vita di tutto il palazzo, aveva aumentato il via vai. Certo un via vai di persone importanti, ma quanto lavoro in più era arrivato per lei. Adesso, quasi ogni giorno, doveva pulire il cortile antistante, lavare l’androne, spolverare il portone d’accesso e lucidarlo, mentre prima - almeno da quanto le aveva sempre detto sua madre – queste incombenze si rendevano necessarie, al massimo, ogni due o tre settimane. Insomma, da quando il Maestro era venuto ad abitare lì, oltre sei anni prima, tutto il lavoro era aumentato. Poi, come se non bastasse tutti, ma proprio tutti, dai vicini sino alle cameriere e perfino i vetturini o anche semplici passanti, la interpellavano volendo sapere del grande compositore, cosa faceva, chi incontrava, cosa mangiava, come si vestiva, se suonava sino a tarda notte … una vera scocciatura; non era mai lasciata un minuto in pace nella sua guardiola. Certo molti ospiti del Maestro - soprattutto le Signore - le lasciavano mance generose quando lei si occupava di cercargli le carrozze in particolare a tarda sera, ma onestamente ne avrebbe fatto anche a meno, perché per ogni carrozza che arrivava e partiva c’era sempre più sporcizia da togliere nel cortile ed anche dentro l’androne; soprattutto quella assai puzzolente lasciata dai cavalli. E poi, come se non bastasse, d’estate doveva tenere ben umido il selciato antistante l’entrata del palazzo e d’inverno spazzare la neve non solo dinanzi al portone – come gli aveva insegnato sua madre – ma su tutto il piazzale là dove sostavano le carrozze a doppio tiro in attesa degli ospiti del Maestro, arrivando a pulire fin quasi davanti all’entrata del palazzo accanto; perché il vecchio Gerd - che lì faceva il portiere - non ne voleva proprio sapere di andare a pulire oltre l’androne antistante la sua guardiola. Toccava quindi a lei curare che tutto fosse in ordine. Ne andava del buon nome del palazzo e soprattutto di lei e della sua famiglia.
La porta che si apriva lentamente la ridestò da quei pensieri e – come sempre – sfoggiò il suo miglior sorriso di circostanza mentre il Maestro apparve sulla soglia dell’appartamento con lo sguardo un po’ assente.
“La carrozza è arrivata ed è davanti al portone Maestro, sono venuta ad informarla” disse scandendo bene le parole ed a voce alta.
Lui annuì. Aveva capito, pensò lei tra sé.
“Quando vuole può scendere. Ha bisogno di qualcosa?” gli chiese, sapendo che non avrebbe ricevuto, come sempre, alcuna risposta.
Lui, abbozzando un mezzo sorriso, annuì. Almeno aveva compreso si disse lei.
Sul fondo dell’appartamento dietro le spalle del Maestro intravide il salotto ed il pianoforte a coda con gli spartiti sparsi qua e là per la stanza. Una confusione che lei non poteva tollerare in casa sua, ma d'altronde sapeva che i compositori erano tutti, senza eccezione, disordinati. Glielo aveva riferito anche la sua amica Gertrude che frequentava lo stesso fornaio vicino al Naschmarkt dove andava la portiera di quel tal Schubert.
Salutò con garbo il Maestro e si girò per tornare in fretta giù, quando d’improvviso sentì la voce di lui che la interpellava: “Mi scusi signorina…”
“Si” rispose guardandolo anche un po’ stupita, perché raramente le aveva rivolto la parola a causa della sordità che lo rendeva schivo ed introverso.
“Posso chiederle il suo nome?” le disse.
“Elisa, Signor Beethoven, Elisa Steiner … per servirla” - rispose - accennando un breve inchino.
“La ringrazio molto... Elisa … E’ proprio un bel nome – mormorò tra sé il Maestro – delicato e soprattutto musicale … Sì! E’ perfetto.”
“La ringrazio - continuò lui - dica al cocchiere in strada che arrivo subito. Adesso ho davvero finito.”
“Sa talvolta - riprese - un nome è quanto di più difficile ci sia da trovare.”
Ed in fretta si girò e rientrò nell’appartamento lasciando la porta aperta.
Lei lo vide che raggiungeva il pianoforte ed annotava qualcosa, un breve appunto, sullo spartito.
“Che tipo!” mormorò tra sé mentre scendeva le scale “sono più di sei anni che vive qui e solo ora chiede il mio nome.”
Uscita dal portone disse al cocchiere che il Maestro sarebbe arrivato subito e quindi si mise a spazzare l’androne con l’abituale misurata lentezza, simile ad un animale che delimita e controlla il proprio territorio.
Poco dopo lui arrivò, attraversò in fretta l’androne e senza nemmeno degnarla di un saluto salì sulla carrozza che partì subito in direzione dell’Hofburg.
Sotto braccio notò che aveva con sé una cartellina da cui sporgevano alcuni spartiti, quasi certamente quelli che aveva notato poco prima dentro l’appartamento.
Quei fogli bianchi da cui certo uscivano, a volte, melodie molto belle e che in molti suscitavano grandissima ammirazione, ma che a lei non erano mai interessate molto.
Quella musica le sembrava infatti troppo raffinata; era il tipo di musica nella quale si dilettavano i ricchi, sua Maestà e quasi l’intera aristocrazia perché non avevano altro da fare - pensava - mentre a lei non avrebbe mai dato da vivere.